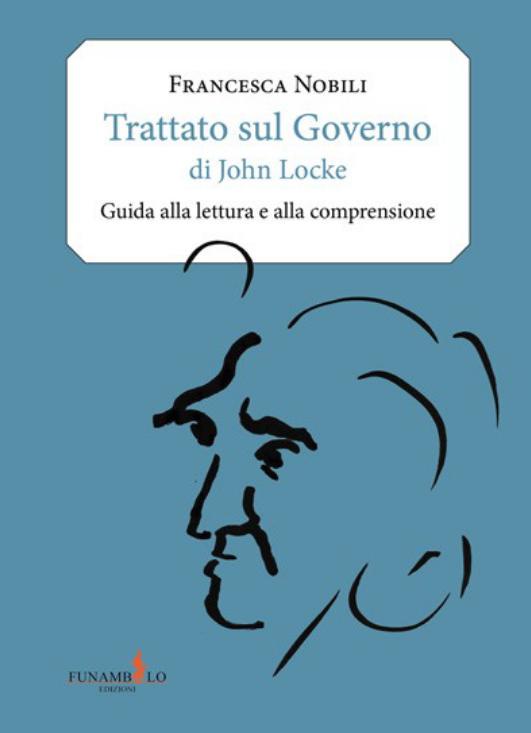«Quanti sono stati già illuminati, hanno gustato i doni
celesti e sono diventati partecipi dello Spirito santo, se incorrono nel
peccato, è impossibile rinnovarli a pentimento». Così recita la Lettera agli
Ebrei (6, 4-6), vietando che potesse essere perdonato e riammesso nella
comunione della Chiesa chi, purificato dei precedenti peccati in forza del
battesimo, fosse incorso successivamente in una grave colpa; il divieto viene
ribadito anche altrove nella lettera.

Nell’ambito della cristianità delle
origini è questa pressoché l’unica testimonianza di una presa di coscienza del
problema posto dal seguace di Cristo che fosse incorso in un grave peccato dopo
il battesimo. In effetti la consapevolezza che il battesimo aveva fatto
rinascere il neofita a nuova vita difficilmente permetteva che si potesse
comunque prendere in considerazione l’eventualità che chi fosse stato
purificato dei peccati della vita precedente in grazia del lavacro battesimale,
potesse di nuovo ricadere nell’abominio della vita precedente.
Ma l’uomo è costituzionalmente fragile e quell’eventualità
si realizza. Forse già l’autore della Lettera agli Ebrei non si limitava a
teorizzare ma aveva di mira qualche fatto concreto di questo genere, e comunque
questa possibilità diventa certezza nella Roma cristiana di Erma, autore del
Pastore, parecchi anni dopo quella testimonianza, intorno al 140. Nel suo
scritto Erma si rivolge ai peccatori post-battesimali della comunità romana,
ripetendo instancabilmente: Vi è ora offerta eccezionalmente la possibilità di
pentirvi dei vostri peccati ed essere riammessi nella Chiesa; affrettatevi
perciò a pentirvi sinceramente, perché il tempo sta per scadere.
Per molto tempo, sulla traccia della proibizione sancita
dalla Lettera agli Ebrei, si era creduto che i peccatori ai quali Erma si
rivolge fossero stati estromessi dalla comunità, ma una considerazione più
attenta della complessa problematica che emerge dal Pastore ci convince che nella
comunità cristiana di Roma intorno alla metà del II secolo non era ancora in
vigore una normativa precisa e vincolante riguardo ai peccatori
post-battesimali. Quello che è certo è che Erma invita i peccatori a cogliere
in fretta la possibilità straordinaria, offerta loro per una sola volta, di
pentirsi dei loro peccati, senza che da lui venga avvertita l’esigenza che il
problema derivante dalla presenza, nella comunità, di questi peccatori fosse
proposto e discusso in modo esplicito.
Era per altro una questione importante, e nella Storia della
Chiesa di Eusebio leggiamo (IV 23) che, intorno al 160, Dionigi, vescovo di
Corinto, ebbe a polemizzare con alcuni colleghi di comunità orientali, che gli
facevano carico di essere troppo propenso a riammettere i peccatori
post-battesimali nella comunità. Sono solo pochi accenni, mentre è ben
altrimenti consistente la nostra documentazione riguardo alla polemica che si
ebbe a Roma, intorno al 220, tra il vescovo Callisto e un ignoto personaggio,
autore di uno scritto, giunto a noi sotto il nome evidentemente falso di
Origene, riguardante le eresie (Èlenchos), intorno al quale si è molto e male
almanaccato e che per comodità definiamo come Autore dell’Èlenchos. È proprio
il suo racconto che, per quanto tutt’altro che obiettivo, ci informa su questi
fatti.
A capo di una conventicola di non molti seguaci, egli
polemizza aspramente con Callisto per motivi di argomento sia dottrinale sia
disciplinare. Quanto ai primi, basterà accennare che egli professava, riguardo
a Cristo, una dottrina che ne accentuava, in quanto Parola (Logos) di Dio
Padre, il carattere personale e compiutamente divino, e che perciò Callisto
considera vera e propria forma di diteismo. Qui ci interessa invece soprattutto
la polemica d’ordine disciplinare: egli fa carico (ix 12) a Callisto di
accogliere nella comunità fedeli che erano incorsi, dopo il battesimo, in
peccati anche molto gravi, al che il vescovo replica che Noè nell’arca aveva
accolto animali puri e impuri senza distinzione, e che nella semina descritta
nel vangelo di Matteo (13, 24-30) insieme col grano cresceva anche la zizania,
e solo dopo che la crescita si fosse completata la zizania sarebbe stata
separata dal grano.
di Manlio Simonetti